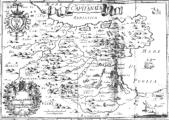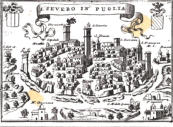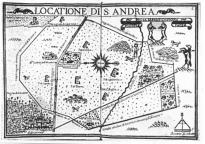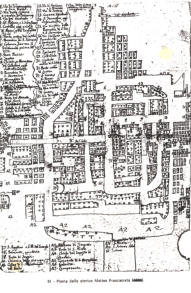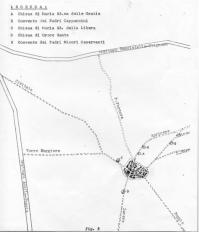IL CD-ROM


“SAN SEVERO 2000”
sanseveropuntoit, 28 ottobre 2025
ANTICHE FONTI ICONOGRAFICHE

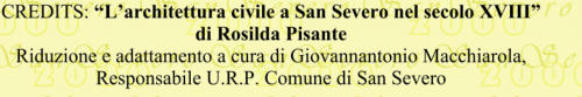
Antiche Fonti Iconografiche
Tra
i
documenti
in
cui
è
riportata
San
Severo,
il
più
antico
di
cui
è
stato
possibile
venire
in
possesso
è
quello
corografico
che
rappresenta
una
reintegra
del
Demanio
operata
dal
Commissario dott. Livio Margarita nel 1577.
Approfondimento
Il
Tito
(
Memorie
della
chiesa
parrocchiale
e
collegiata
di
S.Giovanni
Battista
,
Napoli
1859),
a
proposito
del
possesso
dei
territori
della
Chiesa
di
San
Giovanni
Battista,
scrive:
“I
beni
demaniali
del
Comune
di
S.Severo
a
poco
a
poco
erano
stati
in
gran
parte
usurpati
dai
particolari
cittadini.
Quindi
nel
1577
la
Regia
Camera
della
Sommaria
decretò
la
reintegrazione
del
demanio,
ed
all’oggetto
fu
delegato Commissario il Dottor D. Livio Margarita”.
In
essa
appare
San
Severo,
caratterizzata
com’è
ancora
oggi
dalle
guglie
dei
numerosi
campanili,
molti
dei
quali
subiranno
danni
nei
terremoti
del
1627
e
1731.
Si
nota
anche
l’importantissimo
tratturo regio Aquila-Foggia.
Altro
documento
iconografico
è
rappresentato
da
un
quadro
di
insieme
della
Capitanata
redatto
dall’abate
G.B.Pacichelli
(
Il
Regno
di
Napoli
in
prospettiva
,
Napoli
1703)
il
quale,
nelle
vesti
di
agente
del
duca
di
Parma
e
Piacenza,
visitò
San
Severo
durante
un
suo
viaggio
in
Puglia
nel
1679,
e
in
cui
si
nota
la
numerosità
delle
Chiese
oltre
ad
un
simbolo
che
la
individua
come
sede
Vescovile.
Altri
documenti
iconografici
sono
delle
vedute,
una
dello
stesso
Pacichelli
e
l’altra
del
Coronelli.
Approfondimento
Le
rappresentazioni
del
Pacichelli
e
del
Coronelli,
eseguite
a
breve
distanza
dì
tempo,
nel
1679
e
nel
1706,
ci
mostrano
San
Severo
con
una
notevole
dovizia
di
particolari.
Il
paese
è
circondato
da
mura,
che
se
nella
veduta
del
Pacichelli
mostrano
una
evidente
continuità
(anche
se
a
ben
guardare
sbreccate
e
lesionate
in
vari
punti,
che
stanno
ad
indicare
lo
stato
di
vetustà
e
di
abbandono)
e
appaiono
interrotte
solo
in
corrispondenza
delle
porte
di
Apricena,
di
San
Nicola
e
di
Foggia,
nella
veduta
del
Coronelli
sono
per
ampi
tratti
inesistenti;
ciò
lascia
supporre
una
maggiore
integrazione tra città e territorio.
In
entrambe
le
illustrazioni
svetta
su
tutti
il
campanile
dì
San
Severino
seguito
da
quello
impropriamente
indicato
come
“Vescovado”
che
invece
deve
riferirsi
alla
Chiesa
Cattedrale;
poi
quello
di
San
Francesco,
della
Trinità
e
di
San
Giovanni
Battista.
Altri
piccoli
campanili
sono
pure
presenti
sulle varie chiese, del Carmine, della Pietà, di San Agostino, ecc.
Gli
edifici
indicati
sono
intervallati
da
ampi
spazi
esistenti
nel
tessuto
urbano,
probabilmente
ancora
provato
dalla
estesa
distruzione
del
terremoto
del
1627
e
dalle
successive
scosse
sismiche.
Il
Pacichelli
si
limita
ad
indicare
il
costruito,
il
Coronelli
invece
lo
correda
anche
con
giardini,
aree
verdi,
pozzi,
esistenza
confermata
anche
nel
libro
dello
stato
delle
anime
della Cattedrale del 1724.
All’esterno,
extra
moenia
,
si
individuano
la
chiesa
del
SS.
Rosario,
il
Convento
dei
Cappuccini,
la
Chiesa
di
Santa
Maria
delle
Grazie
e
il
Monastero
dei
Padri
Zoccolanti
o
Minori
Osservanti.
Tali
poli
costituiranno
le
direttrici
di
espansione
della
città
nel
XVIII
secolo;
espansione
che
avverrà
dapprima
verso
le
Grazie
(A)
e
i
Cappuccini
(B)
cioè
via
di
Apricena
(Borgonuovo),
poi
verso
il
Rosario
(C)
fuori
porta
Castello,
lungo
la
via
che
mena
a
Torremaggiore
e
Civitate
(San
Paolo),
poi
verso
porta
San
Nicola
(San
Bernardino)
(E)
per
la
via
che
mena
a
San
Marco
e
San
Nicandro e, verso porta Lucera, la Chiesa di San Rocco o Croce Santa (D).
Altri
documenti
schematici
sono
le
due
tavole
degli
agrimensori
fratelli
Michele
pubblicate
nell’Atlante
della
locazioni:
la
locazione
di
Sant’Andrea
e
la
locazione
di
Arignano (1686).
In
entrambe
appare
San
Severo
vista
da
angolazione
diversa,
circondata
dai
terreni
coltivati
a
vigneti ed uliveti.
Nella
pianura
si
notano
nella
locazione
di
Sant’Andrea
branchi
di
bovini
e
di
pecore
al
pascolo,
che
conferma
la
destinazione
di
vaste
aree.
Si
nota
altresì
che
la
città
è
circondata
da
mura
e
torri.
In
primo
piano
si
individuano
la
porta
del
Castello
e
quella
di
Lucera
ed
è
sempre
presente il “tratturo”.
La locazione di Arignano
Nella
pianta
di
Matteo
Fraccacreta
redatta
intorno
al
1820
con
una
certa
attenzione
ai
rapporti
proporzionali
e
dimensionali,
anche
se
con
approssimazioni
nelle
forme,
si
distinguono,
oltre
al
nucleo
centrale
edificato,
le
case
fuori
le
mura
nelle
direzioni
già
indicate.
La
caratteristica
di
queste
zone
nuove
dì
espansione
è
la
linearità
e
geometria
degli
isolati
che
si
sviluppano
partendo
da
assi
principali,
formando
un
reticolo
con
il
favore
della
natura
pianeggiante
del
territorio.
Nei
secoli
successivi
il
tessuto
urbano
in
espansione
sarà
costituito
da
isolati
chiusi
con
cortili
all’interno,
che
andranno
man
mano
a
coprire,
estendendosi
verso l'esterno, aree più periferiche.
Preziose
indicazioni
in
questo
schema
planimetrico
sono
la
denominazioni
delle
strade
che
sono
qui
per
la
prima
volta
documentato
e
visualizzate.
Si
nota
il
grande
uso
dei
riferimenti:
Piazza
Trinità,
Via
San
Lorenzo,
ecc.,
strade
o
piazze
che
prendono
il
nome
dalle
importanti
realizzazioni
su
cui
prospettano o che lambiscono.
In
tale
figura
sono
anche
riportate
le
ubicazioni
delle
antiche
Porte,
le
4
antiche parrocchie e le relative grancie oltre ai Monasteri.