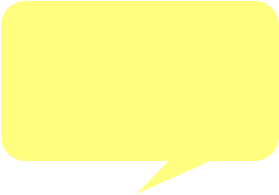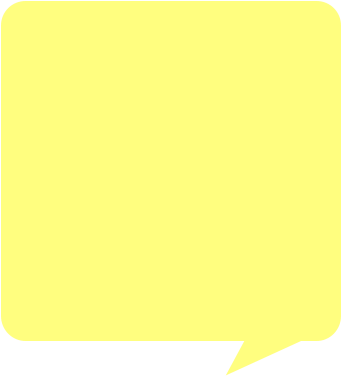DESCRIZIONE ARCHITETTONICA

IL CD-ROM


“SAN SEVERO 2000”
CHIESA DI SAN SEVERINO
ESTERNI
La
facciata
meridionale
duecentesca,
quella
su
Via
Angelo
Fraccacreta,
la
più
antica,
presenta
il
caratteristico
portale
dell’arte
romanica
,
dagli
stipiti
sormontati
da
capitelli
con
foglie
di
acanto
al
di
sopra
dei
quali
è
impostato
l’
architrave
con
cornice
risaltata,
sormontato
da
un
arco
a
tutto
tondo
la
cui
cornice
viene
sostenuta
da
due
leoni,
poggianti
su
mensole
dal
bordo
decorato,
dei
quali è visibile soltanto la parte anteriore del corpo.
La
criniera
stilizzata,
il
muso
aguzzo
che
mostra
i
denti
con
espressione
feroce
e
le
orecchie
ripiegate
in
modo
grottesco
evidenziano
una
plasticità
ancora primitiva.
La
cornice
dell’
arco
a
tutto
tondo
è
decorata
da
foglie
di
forma
ovoidale,
arricciate, dai lunghi steli.
Il
portale
è
sovrastato
dal
rosone
a
sei
raggi,
con
cornice
mistilinea
formata
da
motivi
geometrici
e
motivi
floreali
intrecciati,
coronati
da
un
archivolto
,
con
cornice
analoga
a
quella
del
portale
sottostante,
sostenuto
da
due
colonne
a
tortiglione
sorrette
da
due
leoni
stilofori
,
resi
a
figura
intera,
analoghi
a
quelli del sottostante
portale
ma di dimensioni minori.
Al
di
sopra
del
rosone
in
una
nicchia
è
inserito
un
bassorilievo
raffigurante
San
Severino
assiso,
ornato
dei
paramenti
pontificali,
ai
lati
del
quale
sono
due
angeli
alati;
le
tre
figure
risultano
inserite
in
uno
spazio
architettonico
delimitato
da
tre
archi
sostenuti
da
due
colonne,
delle
quali
sono
ben
visibili
i
capitelli
modanati
, possibile rappresentazione del santo all’interno della chiesa.
Confronto
Identica
soluzione
compositiva
è
adottata
per
la
cattedrale
di
Ruvo
di
Puglia,
realizzata
fra
il
XII
e
il
XIII
secolo,
dove,
al
di
sopra
del
rosone
a
dodici
bracci,
una
nicchia
ospita
la
statua
seduta
di
un
personaggio
variamente
interpretato
come
San
Cleto
o
il
Vescovo
Daniele,
Gilberto
o
l’imperatore
Federico
II,
finanziatore
della
costruzione,
o
più
verosimilmente
come
un
personaggio
apocalittico
che
mostra
il
Libro
dei
Sette Sigilli.
Al
di
sopra
del
bassorilievo
è
un’ampia
finestra
bilobata
e
dalla
cornice
mistilinea
che
richiama
per
la
sua
forma
la
finestrina
inserita
nel
timpano
della facciata ovest.
La
facciata
sud
della
chiesa
confina
sulla
destra
con
quella
di
un
palazzetto
caratterizzato,
al
primo
piano,
da
una
finestra
bifora
,
inserita
in
un
arco
cieco
,
che richiama quella del secondo piano del campanile.
Al
di
sopra
del
portale
principale,
quello
con
la
data
1224,
si
apre
una
finestra
centrale
dalla
caratteristica
forma
trilobata
,
i
cui
due
lobi
inferiori
sono
separati
da
un
davanzale
dalla
cornice
multipla,
al
centro
del
quale
si
apre
una
finestra
bilobata
identica
nella
forma
a
quella
della
facciata
meridionale
ma
di
dimensioni
ridotte.
Al
di
sopra,
in
una
nicchia
centrale,
è
alloggiata
la
piccola
statua
di
San
Severino assiso e indossante vesti cerimoniali.
Il
timpano
superiormente
è
decorato
da
un
motivo
a
volute
che
corre
per
tutta
la sua lunghezza fino alle estremità sottolineate dai vasi di coronamento.
Il
frontone
triangolare
viene,
in
epoca
barocca
,
arricchito
da
elementi
decorativi
di
coronamento,
quali
volute
,
cartocci,
vasi
dalla
composizione
fantasiosa
e obelischi posti alle estremità del
cornicione
.
Confronto
La
cattedrale
di
Candela,
ad
esempio,
ha
il
timpano
con
volute
come
la
cattedrale
di
Foggia,
che
presenta
in
più
i
vasi
angolari
di
coronamento.
Entrambe
riportano
a
già
sperimentate
soluzioni
a
Napoli
nel
XVII
secolo
nelle
facciate
delle
chiese
barocche,
entrambe
progettate
da
Cosimo
Fanzago
,
di
Santa
Teresa
agli
Studi
con
le
volute
sulle
falde
del
timpano
e
di Santa Teresa a Chiaia con statue ed obelischi di coronamento.
Approfondimento
Il
romanico
pugliese
rappresenta
una
stagione
creativa
caratterizzata
da
un
linguaggio
originale,
sempre
diverso
e
avulso
da
ogni
provincialismo.
Sui
precedenti
elementi
bizantini
si
innestano
gli
influssi
del
romanico
lombardo.
Il
finissimo
dettaglio
decorativo
applicato
alle
parti
nodali
della
struttura
è
di
derivazione
greco-bizantina.
Gli
scalpellini
e
gli
scultori
trasformano
i
capitelli
e
le
mensole
in
figurazioni
scolpite,
bizzarre
nelle
forme
e
nelle
proporzioni,
anche
grottesche,
nelle
quali
ogni
immagine,
ogni
forma
visibile,
è
forma
dell’essere
e
ogni
forma
dell’essere
è
forma
di
Dio,
come
teorizzato
da
Scoto
Eriugena
,
filosofo
e
teologo
irlandese
del
IX
secolo,
ma
più
semplicemente
in
figurazioni
dal
significato
morale,
simboli
atti
ad
istruire
fedeli
nella
dottrina
cristiana.
Le
mensole
dei
leoni
stilofori
dell’
archivolto
recano
il
motivo
dell’Albero
della
Vita,
così
come
la
Porta
dei
Leoni
sul
lato
nord
della
basilica
di
San
Nicola
a
Bari
presenta
capitelli
scolpiti
con
l’allegoria
delle
stagioni,
mietitura
per
l’estate
nel
capitello
di
sinistra
e
vendemmia
per
l’autunno
in
quello
di
destra,
interpretabile
sia
come
rappresentazione
dei
periodi
della
vita
terrena
dell’uomo,
sia
come
metafora
dei
frutti
della
ricompensa
ultraterrena
che
possono
essere
conquistati
unicamente
per
merito
della
Fede.
La
funzione
propedeutica
e
politico-morale
dell’architettura
è
presente
sia
nelle
opere
civili
sia
in
quelle
religiose.
Confronto
Il
portale
della
Cattedrale
di
Altamura,
ad
esempio,
è
arricchito
in
tutte
le
sue
parti,
da
sculture
che
compongono
l’intero
Ciclo
Evangelico,
dall’Annunciazione
fino
alla
Pentecoste,
esemplificazione
della
cosiddetta
“Bibbia
dei
poveri”
medievale,
con
la
quale
il
catechismo
veniva
illustrato,
mediante
immagini,
ai
fedeli,
la
stragrande maggioranza dei quali era analfabeta.
Il
Peccato
originale,
l’Angelo
e
il
personaggio
civile
in
cattedra
sono
le
raffigurazioni
delle
tre
mensole
della
loggia
dello
scalone
settentrionale
del
Castello
federiciano
di
Trani,
costruito
fra
il
1233
e
il
1249.
I
leoni
stilofori
richiamano
quelli
del
portal
e
del
Duomo
di
Sovana
(Grosseto),
datato
al
IX-XI
secolo
e
successivamente
ricostruito
tra
il
XII
e
il
XIII
secolo,
mentre
l’insieme
strutturale
riporta
ai
portali
delle
facciate
delle
Cattedrali
di
Bovino
e
di
Troia,
entrambe
nel
Foggiano,
e
a
quello
della
chiesa
di
santa
Maria
dei
Franconi
a
Veroli (Frosinone), datata all’XI-XII secolo.
La
finestrina
lobata
del
timpano
,
con
la
cornice
mistilinea
di
gusto
meridionale,
richiama
esempi
romani,
quali
le
lunette
della
cupola
della
chiesa
interna
dell’Ospedale
di
San
Gallicano
a
Roma,
realizzata
da
Filippo
Raguzzini
nel
1725,
mentre
come
semplice
elemento
decorativo
si
ritrova
sopra
ciascuna
delle
finestre
del
primo
piano
della
palazzina Gentilini sulle Mura Aureliane, sempre a Roma.
Richiami
pugliesi
sono
costituiti
dalla
finestrina
del
timpano
della
facciata
della
cattedrale
di
Bari,
di
forma
polilobata
e
con
cornice
mistilinea
o
le
finestre,
bilobate
sui
lati,
affacciate
sulle
logge
delle
abitazioni
settecentesche
di
Martina
Franca,
eleganti
esempi
del
barocchetto
meridionale,
che
per
mezzo
della
cornice
in
pietra
grigia
risaltano sull’intonaco bianco delle pareti.
La
finestra
trilobata
posta
sul
portale
della
facciata
ovest
della
chiesa
di
San
Severino
riporta
alle
finestre
polilobate
sperimentate
a
Roma
da
qualche
artigiano
nella
bizzarra
facciata
barocca
ad
andamento
concavo,
a
finta
esedra
,
ai
piedi
degli
Orti
Farnesiani
del
Palatino
in
Via
dei
Cerchi,
e
nella
facciata
del
chiostro
di
San
Gregorio
Magno
al
Celio,
realizzata
insieme
agli
interni
da
Francesco
Ferrari
tra
il
1725
e
il
1734.
I
due
portali
laterali
della
facciata
principale
della
Cattedrale
di
Bari,
sovrapposti
ai
semplici
portali
architravati
dell’XI
secolo,
in
occasione
della
ristrutturazione
del
XVIII
secolo,
recano
ciascuno,
al
di
sopra
della
cornice
,
una
finestra
polilobata
,
dalla
vaga
forma
triangolare,
incorniciata
da
elementi
mistilinei
,
che
si
collega
direttamente
alle
finestre
polilobate
delle
due
facciate
della
chiesa
di
San
Severino
,
analogamente
all’occhio
della
facciata,
al
posto
del
rosone, dalla forma
trilobata
e dalla
cornice
mistilinea
.
Lo
sviluppo
di
linee
curve
rientra
nello
sviluppo
del
barocco
tardo-
meridionale,
come
la
chiesa
dell’Addolorata
a
Serra
San
Bruno
(Catanzaro),
dove
il
finestrone
centrale
della
facciata,
di
vaga
forma
romboidale,
presenta
la
forma
polilobata
sottolineata
dalla
cornice
mistilinea
,
accentuata
dalle
volute
laterali
inferiori,
influssi
che
giungono
dalla
costa
tirrenica,
esattamente
da
Paola
(Cosenza),
dove
il
tardo
barocco
nel
corso
della
seconda
metà
del
XVIII
secolo
ha
vissuto
la
sua
stagione
migliore
e
da
Napoli,
avendo
Cosimo
Fanzago
lavorato
a
lungo
a
Serra
San
Bruno
per
la
realizzazione
dell’arredo
interno della Certosa di santo Stefano del Bosco.
La
compresenza
degli
elementi
decorativi
calligrafici
dell’età
romanica,
attinti
dai
repertori
classici
e
greco-bizantini,
con
quelli
architettonico-strutturali
dell’epoca
barocca
,
testimonia
la
persistente
funzione
catalizzatrice
della
chiesa
all’interno
della città.
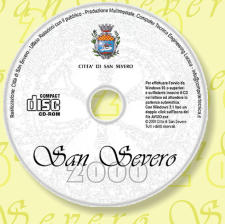

















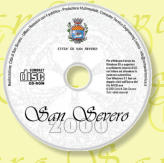

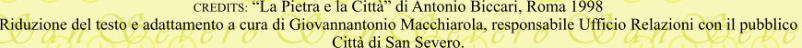

sanseveropuntoit, 14 luglio 2025