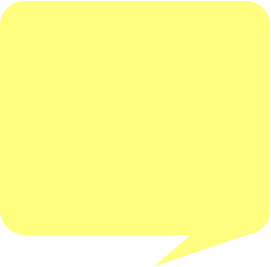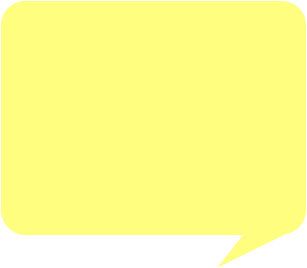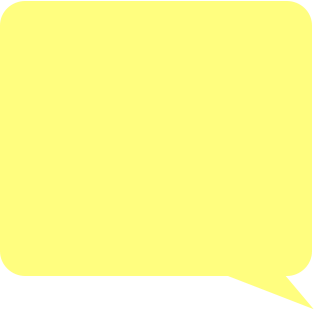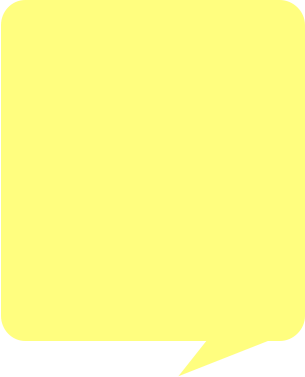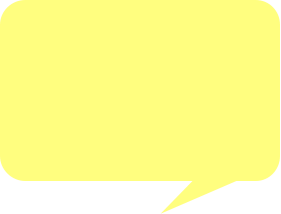SANTUARIO
DELLA BEATA VERGINE DEL SOCCORSO
DESCRIZIONE ARCHITETTONICA
ESTERNI
L’isolato
della
chiesa
sorge
fra
le
centralissime
Via
Soccorso
e
Via
dei
Quaranta,
fra i laterali vicolo Vaglio e Via De Girolamo, con ingresso in Via Soccorso.
La
facciata,
dalla
suddivisione
in
due
ordini
e
la
tripartizione
verticale
caratteristiche
dell’arte
sacra
di
epoca
barocca
,
presenta
il
portale
centrale,
dall’ampia
cornice
inornata,
sormontato
dallo
stemma
con
l’immagine
della
Madonna
con
il
Bambino
in
braccio,
entrambi
recanti
mazzi
di
spighe
e
di
fiori nelle mani.
La
cornice
dello
stemma,
costituita
dalle
ampie
volute
laterali,
dalla
conchiglia
inferiore
e
dal
fregio
interno
mistilineo
,
riprende
lo
stile
diffuso
a
San
Severo,
comune
all’architettura
religiosa
e
civile
nel
XVIII
secolo,
influenzato
dalla
presenza del celebre architetto napoletano Astarita o
Astarite
.
Le
lesene
che
affiancano
il
portale
sono
sormontate
da
ricchi
capitelli
con
volute
che
si
raccordano
alla
superficie
della
facciata
mediante
analoghe
volute
che
sporgono plasticamente.
I
corpi
laterali
sono
caratterizzati
dalla
flessione
interna
delle
pareti
al
fine
di
ottenere
un
movimento
ondulato
interessante
l’intera
superficie
della
facciata,
concavo laterale e a diaframma lineare centrale.
Confronto
Tale
movimento
ondulato
ha
visto
la
sua
evoluzione
a
Roma
nel
corso
del
XVII
secolo,
dalla
chiesa
di
Santa
Susanna
di
Carlo
Maderno
(1612)
a
quella
di
San
Carlo
alle
Quattro
Fontane
di
Francesco
Borromini
(1667).
Le
parti
laterali,
sottolineate
da
una
cornice
mistilinea
che
forma
ampie
specchiature
,
recano
le
lapidi
in
ricordo
della
incoronazione
della
Madonna
a
Patrona
della
città,
avvenuta
l’8
maggio
1937,
sulla
parete
di
sinistra,
e
della
elezione
della
chiesa
a
Santuario
Mariano
decretata
nel
1957, sulla parete di destra.
Entrambe
le
lapidi
presentano
una
ricca
cornice
sormontata
da
una
grande
conchiglia,
al
di
sotto
della
quale
sono
stati
ricavati
a
rilievo
motivi
decorativi
composti da girali e motivi
fitomorfi
misti.
Particolare
è
la
soluzione
architettonica
che
determina
e
chiude
gli
angoli
della
facciata,
costituiti
da
una
semicolonna
liscia,
inserita
all’interno
dello
spazio
formato
dalle
lesene
poste
d’angolo,
sormontata
da
un’elaborata
cornice
a segmenti paralleli orizzontali.
Confronto
Tale
soluzione
d’angolo
riprende,
ad
esempio,
quella
interessante
il
portale
del
Convento
dei
Chierici
Minori
in
Via
del
Lavatore,
a
Roma,
realizzato
da
Melchiorre
Passalacqua
intorno
agli
anni
Settanta
del
XVII
secolo,
dove
l’angolo
formato
dalla
cornice
del
portale
impostata
sulla
superficie
della
facciata
viene
riempito
da
lunghe
mensole
cilindriche
che
si prolungano in
stipiti
concavi.
L’ordine
superiore
del
Santuario
Mariano
sanseverese
ripete
la
tripartizione
verticale
di
quello
inferiore,
le
ampie
specchiature
delle
pareti
e
l’ondulazione
della
superficie ottenuta mediante le rientranze laterali.
Di
altezza
minore,
la
superficie
è
unicamente
scandita
dalle
lesene
inornate
a
rilievo,
prive
dei
capitelli
,
dalle
specchiature
delle
concavità
laterali,
dai
nudi angoli terminali.
La
parte
centrale,
superiore
al
portale
,
comprende
un
ampio
finestrone
di
forma
irregolare,
con
arco
superiore
e
lati
leggermente
strombati
nella
parte
inferiore.
Tale
innovazione
compositiva
ricorda
gli
esperimenti
formali
interessanti
le
finestre
delle
due
facciate
della
chiesa
di
San
Severino,
realizzati nella prima metà del XVII secolo.
Nella
nicchia
di
sinistra,
incorniciata
da
girali
inferiori
e
da
una
coppia
di
volute
contrapposte
terminanti
in
motivi
floreali,
è
inserita
la
statua
di
Sant’Agostino
,
in
atto
benedicente,
vestito
dei
paramenti
episcopali,
e
nella
nicchia
di
destra
quella
di
San
Isidoro
Agricolo,
vissuto
in
Spagna
nel
XIII
secolo,
con
vestiti
alla
foggia
del
suo
tempo,
entrambe
realizzate
dai
fratelli
Pietro e
Gregorio Palmieri
intorno al 1780.
Il
timpano
che
conclude
superiormente
la
facciata
è
impostato
sulla
cornice
risaltata
dell’ordine
superiore
e
presenta
una
finestra
di
forma
circolare
dalla
pesante
cornice
.
Le
cuspidi
,
che
si
dipartono
dai
vasi
di
coronamento
angolari,
seguono
l’andamento
della
cornice
,
composta
da
un
gioco
di
sporgenze
e
di
rientranze
culminante
in
due
volute
contrapposte,
dalle
quali
si
erge
il
vertice
sostenente
la
base
polilobata
della croce.
Confronto
Riguardo
questa
soluzione
decorativa,
nel
suo
complesso,
si
ravvisano
i
precedenti
nelle
facciate
delle
chiese
sanseveresi
del
Carmine,
già
Santa
Croce
al
Mercato,
del
1743,
dove
la
decorazione
risulta
calligrafica
e
la
sovradimensione
dei
singoli
elementi
domina
l’insieme
compositivo,
e
dei
Padri
Celestini,
già
della
Santissima
Trinità,
datata
al
primo
ventennio
del
XVIII
secolo,
dove
la
cornice
mistilinea
,
di
dimensioni
imponenti,
riesce
a
sorreggere
interamente
le
volute
,
caratterizzate
da
una
forte
esuberanza
volumetrica, e i terminali decorativi angolari del
coronamento
.

IL CD-ROM


“SAN SEVERO 2000”
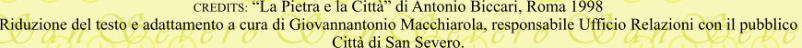













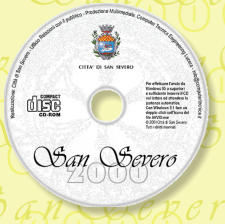
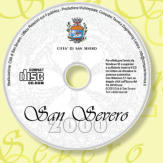


sanseveropuntoit, 14 luglio 2025