
IL CD-ROM


“SAN SEVERO 2000”

sanseveropuntoit, 5 novembre 2025
La musica del sito

Le maestranze
Nel
XVII
secolo
a
Napoli,
nelle
opere
di
trasformazione
e
nelle
aggiunte
dell’assetto
urbano,
la
figura
dell’architetto
e
dell’artista
in
genere
non
veniva mai esaltata né le si dava un ruolo di primo piano.
Non
c'è
quindi
da
meravigliarsi
se
dei
bei
palazzi
costruiti
a
San
Severo
nel
secolo
XVIII
si
ignora
il
nome
dell’architetto
e
del
maestri
decoratori.
Tali
personaggi
erano
privi
di
“autorità
intellettuale
ed
importanza
sociale”
e
le
loro opere venivano spesso cancellate dalla scena urbana senza alcuna pietà.
Approfondimento
Per
esempio,
nel
manoscritto
della
famiglia
del
Sordo
nei
luoghi
in
cui
si
annotano
gli
interventi
nella
costruzione
e
le
varie
modifiche
apportate
al
grande
complesso
edilizio
in
via
Soccorso
non
si
cita
il
nome
dell’architetto
e
neanche
quello
dello
scultore
che
eseguì
i
sette
mascheroni
portanelli
in
pietra
calcarea
locale
posti
sulla
parete
principale
del
piano
terra.
Compare,
invece,
colui
che
eseguì
lavori
di
restauro
e
valutò
l’edificio
più
volte,
a
motivo
dei
molteplici
testamenti
del
rev.
D.
Francesco
del
Sordo
(proprietario
di
una
parte
del
palazzo)
e
cioè
il
“maestro
muratore”
Michele
Iannelli,
il
quale,
misurò
e
valutò
il
fabbricato,
oltre
ad
attendere
ai
lavori
di
costruzione.
Evidentemente
i
proprietari
dovevano
avere
molta fiducia nel capomastro.
Michele
lannelli,
poi,
faceva
parte
di
quella
famiglia
di
maestri
muratori
che
realizzò
tante
opere
architettoniche
di
particolare
prestigio
nella
città.
Sappiamo
infatti
di
Berardino
Iannelli
che
“fabbricò”
la
Chiesa
di
San
Sebastiano
(oggi
anche
Chiesa
di
Maria
SS.
della
Libera)
fuori
le
mura,
nella
prima
metà
del
Settecento
e
del
figlio
Pasquale
che
eseguì
i
lavori
di
costruzione
della
Chiesa
di
San
Lorenzo
nel
1778-79,
disegnata
dall’architetto
Giuseppe
Astarita
di
Napoli
(unica
opera
a
San
Severo
di
cui finora si conosce il nome dell’architetto).
In
questo
momento
particolarmente
intenso
nella
storia
dell’edilizia
sanseverese
sia
civile
che
ecclesiastica
una
intera
famiglia
di
maestri
muratori svolge probabilmente un ruolo di primo piano nella città.
E'
utile
ricordare
che
nello
stato
delle
anime
del
1724
della
Cattedrale,
S.
Maria
in
Strada,
pubblicato
dal
Corsi,
nell’antico
Convento
di
San
Rocco
fuori la porta di Lucera si cita la “nascente congregazione degli artisti”.
A
tale
notizia
si
devono
aggiungere
i
nomi
di
pittori,
scultori,
stuccatori
e
scalpellini
rintracciati
da
A.Gambacorta:
Sebastiano
Marvocca
di
San
Severo,
scultore
in
legno,
operante
a
Foggia
nel
1729;
Gregorio
Palmieri
a
cui
è
attribuita
la
statua
del
Cristo
alla
colonna
del
1790
nella
Chiesa
dei
Celestini
e
Gennaro
Trilocco
operante
a
Napoli
nel
1794
a
cui
si
attribuisce
la
statua
della
Beata
Vergine
del
Carmelo
nella
Chiesa
del
Carmine;
ancora
Vitantonio
Petruccelli
del
quale
non
si
conoscono
opere
firmate,
ma
il
cui
titolo
di
“artista”
e
documentato
nel
“catasto
onciario
di
San
Severo
dell'anno 1753”.
Approfondimento
Osiamo
pensare
che
anche
l’autore
della
eleganti
bussole
in
legno
intagliato
della
casa
Summantico
e
quelle
del
palazzo
del
Sordo
di
via
Soccorso
che
recano
sull’architrave
raffinate
maschere
di
guerriero,
presenti
pure
sui
capitelli
delle
lesene
d’angolo
di
palazzo
Marano
di
fronte
alla
Chiesa
di
San
Nicola
(questi
scolpiti
nel
mattone) faccia parte di questo elenco di maestri qualificati.
A
costoro
potremmo
aggiungere
i
nomi
di
due
artisti
conosciuti,
solo
perché
esplicarono
la
loro
arte
come
stuccatore
e
scalpellino
per
le
Chiese
di
San
Lorenzo
e
di
San
Nicola
nella
seconda
metà
del
Settecento,
e
cioè
Ambrogio
Piazza
di
Venezia
e
Francesco
Cervone
da
San
Severo.
Ad
essi
si
possono
probabilmente
attribuire
anche
pregevoli
episodi
decorativi
della
architettura
civile:
per
esempio
le
eleganti
decorazioni
presenti
nella
cupola
a
semicalotta
della
loggia
del
Palazzo
di
Lembo
e
nelle
volte
delle
scale
del palazzo Giuliani.
TIPOLOGIA DEL PALAZZO SIGNORILE
NEL SEI-SETTECENTO


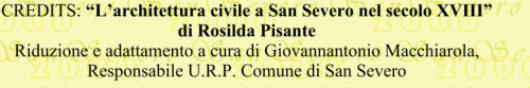
Indice:
L’assetto urbanistico prima del terremoto del 1627
La “ricostruzione” dalla seconda metà del 1600
Tipologia del palazzo signorile
Le maestranze





