
IL CD-ROM


“SAN SEVERO 2000”

sanseveropuntoit, 5 novembre 2025



Le porte
La
città
è
formata
da
presso
il
“Giro
Esterno”
dì
una
cinta
muraria
con
sette
porte
da
cui
si
accedeva
nella
città
provenendo
dalle
varia
località
limitrofe.
La
Porta
Apricena
fu
demolita
probabilmente
prima
del
1679
perché
non
presente
nella
veduta
di
San
Severo
rilevata
in
quell’anno
dal
Pacichelli.
Essa
occupava
l’area
tra
il
muro
occidentale
del
vecchio
giardino
del
Monastero
delle
Benedettine
e
le
case
di
fronte.
Veniva
denominata
anche
“porta
carrese”
probabilmente
per
il
passaggio
dei
carri
che
vi
pagavano
il
pedaggio.
La
Porta
Castello
presso
la
Chiesa
di
San
Giovanni
Battista,
era
chiamata
così
perché
si
apriva
nei
pressi
del
Castello
Drione
“
là
dove
oggi
sono
le
case
del
sig.
Recca
e
del
consigliere
Tondi
“
come
dice
Matteo
Fraccacreta
nel suo
Teatro
.
Il
Castello
in
gran
parte
sporgeva
fuori
le
mura
e
Antonio
Lucchino
dice
che
“
verso la parte destra nell’entrata della Porta vi erano profondi fossi
”.
La
Porta
di
Foggia,
demolita
nel
1838,
si
apriva
fra
i
due
palazzi
del
Sordo.
La
Porta
San
Nicola,
munita
di
“
cataracta
”
o
saracinesca
fu
demolita
nel
1825.
La
Porta
del
Mercato
o
dei
Morti
(perché
attraverso
di
essa
si
accedeva
alla
piazza
del
Mercato
con
la
chiesetta
dell’Adorazione
o
dei
Morti
o
della
Pietà
o
di
San
Giuseppe);
con
i
fossi
attorno
e
mura
con
alte
torri,
era
ubicata di fronte all'ingresso del palazzo de Ambrosio, allora fuori le mura.
La Porta di Lucera si apriva verso Lucera.
La
Porta
San
Antonio
Abate
ora
collocata
presso
la
chiesa
omonima
e
l’ospedale.
L’area
attorno
alle
porte
era
punto
di
richiamo
per
i
patrizi
della
città
(
massari
e
mercanti)
che
qui
costruirono
le
loro
dimore,
spesso
grandi
complessi
edilizi
accanto
ai
Monasteri.
L’importanza
della
porta
cittadina
è
provata,
anche,
dall’episodio
di
cui
è
protagonista
la
famiglia
del
Sordo
abitante
nel
palazzo
in
Via
Soccorso.
I
del
Sordo,
infatti,
ebbero
in
data
4.5.1741
dalla
Magnifica
Università
della
città
di
San
Severo,
la
concessione
dell’antica porta, detta di Foggia, e fecero costruire una stanza sopra di essa.
I
palazzi
gentilizi
si
raggruppano
nei
punti
chiave
della
città
e
cioè
presso
le porte e i Monasteri.
Questi
ultimi
avevano
notevole
peso
nella
vita
economica
dell’Università
sanseverese
e
la
loro
presenza,
certamente
servì
da
modello
e
stimolo
per
la
costruzione
e
decorazione
delle
case
palazziate
che
spesso
sorsero
nelle
zone
ad essi adiacenti.
La
porte
poi
avevano
molta
importanza
sia
per
i
privati
che
per
gli
ecclesiastici.
Presso
la
porte
della
città,
all’interno,
si
concentrava
l’attività
commerciale
esplicata
nelle
fiere,
dove
si
vendevano
gli
animali
ed
i
prodotti
che
produceva
la
terra
ed
è
presso
le
porte
che
si
raggruppavano
le
fosse
granarie, dapprima entro le mura e poi “
extra-moenia
”.
In
Capitanata
il
grano
era
conservato
sin
dal
Medioevo
in
fosse
che,
nel
periodo
di
Federico
II,
erano
chiamate
“
Granatarie
”
(de
Ambrosio).
Le
fosse
granarie
in
San
Severo
erano
della
capacità
fino
a
1500
ettolitri
e
venivano
scavate
nel
sottosuolo
e
realizzate
con
conci
di
pietra
calcarea,
squadrati
e
perfettamente
combacianti
tra
loro.
La
capacità
delle
fosse
si
misurava in tomoli (unità di misura locale).
Le fosse granarie
Approfondimento
In
Foggia,
verso
il
1725,
l’uso
delle
fosse,
dapprima
sorto
come
iniziativa
privata,
riunì
i
conduttori
di
terre,
che
venivano
a
depositare
nelle
fosse
il
grano,
in
una
“
corporazione
dei
massari
di
campo
”
Per
il
lavoro
che
richiedeva
il
prelevamento
del
grano
dalle
fosse
si
costituirono
le
compagnie
di
misuratori
e
sfossatori
che
presero il nome di “
carlentini
”.
A
San
Severo,
le
compagnie
dei
“
carlentini
”
erano
quattro:
di
Sant’Onofrio
a
Largo
Carmine,
di
Croce
Santa
a
Largo
Sanità,
di
San
Francesco (Largo del Castello) e delle Grazie presso Porta Apricena.
Tali
depositi,
dapprima
ubicati
nell’ambito
della
cerchia
muraria,
con
l’espandersi
della
città
andarono
ad
interessare
zone
più
periferiche,
sempre
però
nella
direzione
di
strade
di
accesso
al
paese,
come
fuori
porta
Castello,
porta Lucera, ecc.
Le
fosse
più
antiche
erano
in
genere
ubicate
in
prossimità
delle
case
dei
proprietari sia privati che enti ecclesiastici.
configurazione urbana
DI SAN SEVERO nel Settecento
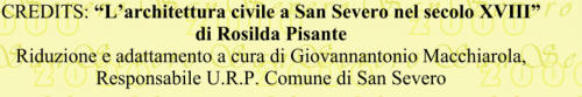







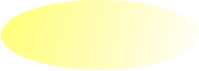
La musica del sito

